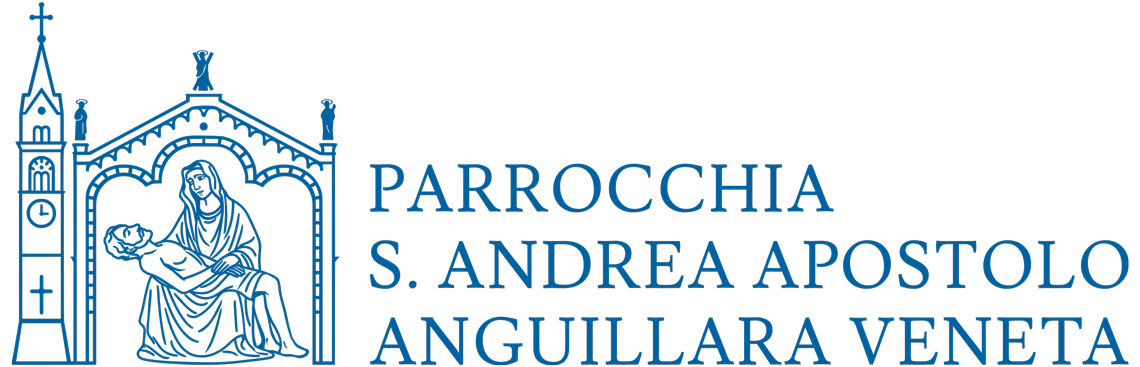Ai Partecipanti allIncontro mondiale dei Movimenti Popolari (23 ottobre 2025)
Cari fratelli e sorelle,
è la prima volta che ho la gioia di incontrarvi, proseguendo nel cammino iniziato da Papa Francesco che, in questi anni, ha dialogato spesso con la vostra realtà, mettendone in luce l’importanza profetica nel contesto di un mondo segnato da problematiche di vario genere.
Uno dei motivi per cui ho scelto il nome “Leone XIV” è l’Enciclica Rerum novarum, scritta da Leone XIII durante la rivoluzione industriale. Il titolo Rerum novarum significa “cose nuove”. Ci sono certamente “cose nuove” nel mondo, ma quando diciamo questo, in genere adottiamo uno “sguardo dal centro” e ci riferiamo a cose come l’intelligenza artificiale o la robotica. Tuttavia, oggi vorrei guardare alle “cose nuove” con voi, partendo dalla periferia.
Vedere le “cose nuove” dalla periferia
Più di dieci anni fa, qui in Vaticano, Papa Francesco vi ha detto che eravate venuti per piantare una bandiera. Cosa c’era scritto? “Terra, casa e lavoro”. [1] “Tierra, techo, trabajo”, come ci ha detto Guadalupe poco fa. Era una “cosa nuova” per la Chiesa, ed era una cosa buona! Facendo eco alle richieste di Francesco, oggi dico: la terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri, vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire “Ci sto!”, “sono con voi”!
Chiedere terra, casa e lavoro per gli esclusi è una “cosa nuova”? Visto dai centri del potere mondiale, certamente no; chi ha sicurezza finanziaria e una casa confortevole può considerare queste richieste in qualche modo superate. Le cose veramente “nuove” sembrano essere i veicoli autonomi, oggetti o vestiti all’ultima moda, i telefoni cellulari di fascia alta, le criptovalute e altre cose di questo genere.
Dalle periferie, però, le cose appaiono diverse; lo striscione che sventolate è così attuale che merita un intero capitolo nel pensiero sociale cristiano sugli esclusi nel mondo di oggi.
Questa è la prospettiva che desidero trasmettere: le cose nuove viste dalla periferia e il vostro impegno che non si limita alla protesta, ma cerca soluzioni. Le periferie spesso invocano giustizia e voi gridate non “per disperazione”, ma “per desiderio”: il vostro è un grido per cercare soluzioni in una società dominata da sistemi ingiusti. E non lo fate con microprocessori o biotecnologie, ma dal livello più elementare, con la bellezza dell’artigianato. E questa è poesia: voi siete “poeti sociali”. [2]
Oggi portate di nuovo lo stendardo della terra, della casa e del lavoro, camminando insieme da un centro sociale – Spin Time – al Vaticano. Questo camminare insieme testimonia la vitalità dei movimenti popolari come costruttori di solidarietà nella diversità. La Chiesa deve essere con voi: una Chiesa povera per i poveri, una Chiesa che si protende, una Chiesa che corre dei rischi, una Chiesa coraggiosa, profetica e gioiosa!
Ciò che ritengo più importante è che il vostro servizio sia animato dall’amore. Conosco realtà ed esperienze simili presenti in altri Paesi, veri e propri spazi comunitari pieni di fede, speranza e soprattutto di amore, che rimane la virtù più grande di tutte (cfr 1Cor 13,13). Infatti quando si formano cooperative e gruppi di lavoro per sfamare gli affamati, dare riparo ai senzatetto, soccorrere i naufraghi, prendersi cura dei bambini, creare posti di lavoro, accedere alla terra e costruire case, dobbiamo ricordarci che non si sta facendo ideologia, ma stiamo davvero vivendo il Vangelo.
Al centro del Vangelo, infatti, c’è il comandamento dell’amore, e Gesù ci ha detto che nel volto e nelle ferite dei poveri è nascosto il suo stesso volto (cfr Mt 25,34-40). È bello vedere che i movimenti popolari, prima ancora che dall’esigenza della giustizia, sono mossi dal desiderio dell’amore, contro ogni individualismo e pregiudizio.
Come Vescovo in Perù, sono felice di aver sperimentato una Chiesa che accompagna le persone nei loro dolori, nelle loro gioie, nelle loro lotte e nelle loro speranze. Questo è un antidoto contro un’indifferenza strutturale che si va diffondendo e che non prende sul serio il dramma di popoli spogliati, derubati, saccheggiati e costretti alla povertà. Spesso ci sentiamo impotenti dinanzi a tutto questo, eppure, a questa che ho definito «globalizzazione dell’impotenza», dobbiamo iniziare ad opporre una «cultura della riconciliazione e dell’impegno». [3] I movimenti popolari colmano questo vuoto generato dalla mancanza di amore con il grande miracolo della solidarietà, fondata sulla cura del prossimo e sulla riconciliazione.
Come dicevo, il normale discorso sulle “cose nuove” – con le loro potenzialità e i loro pericoli – omette ciò che accade alla periferia. Dal centro c’è poca consapevolezza dei problemi che colpiscono gli esclusi, e quando se ne parla nelle discussioni politiche ed economiche, si ha l’impressione che si tratti di «una questione aggiunta quasi per dovere o in modo tangenziale, se non trattata semplicemente come un danno collaterale. In effetti, alla fine dei conti, spesso rimangono in fondo alla lista delle priorità». [4] Al contrario, i poveri sono al centro del Vangelo. Perciò, le comunità emarginate dovrebbero essere coinvolte in un impegno collettivo e solidale volto a invertire la tendenza disumanizzante delle ingiustizie sociali e a promuovere uno sviluppo umano integrale.
Infatti, «finché i problemi dei poveri non saranno risolti in modo radicale, rifiutando l’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e affrontando le cause strutturali della disuguaglianza, non si troverà alcuna soluzione ai problemi del mondo o, per meglio dire, a nessun problema. La disuguaglianza è la radice dei mali sociali». [5]
Vecchie ingiustizie nel nuovo mondo
Il vostro impegno si fa tanto più necessario in un mondo che, come sappiamo, è sempre più globalizzato; come affermava Benedetto XVI «i processi di globalizzazione, se adeguatamente compresi e orientati, aprono possibilità senza precedenti di ridistribuzione su vasta scala della ricchezza a livello mondiale; se invece sono mal orientati, possono portare ad un aumento della povertà e delle disuguaglianze e potrebbero persino innescare una crisi globale». [6]
Questo significa che i dinamismi del progresso vanno sempre gestiti attraverso un’etica della responsabilità, superando il rischio dell’idolatria del profitto e mettendo sempre l’uomo e il suo sviluppo integrale al centro. L’“umano” è al centro della visione di sant’Agostino di un’etica della responsabilità. Egli ci insegna come la responsabilità, specialmente nei confronti dei poveri e di coloro che hanno bisogni materiali, nasce dall’essere umani con i propri simili e, quindi, dal riconoscimento della nostra “comune umanità”. [7]
Poiché condividiamo tutti la stessa umanità, dobbiamo assicurarci che le “novità” siano gestite in modo adeguato. La questione non dovrebbe rimanere nelle mani delle élite politiche, scientifiche o accademiche, ma dovrebbe invece riguardare tutti noi. La creatività di cui Dio ha dotato gli esseri umani e che ha generato grandi progressi in molti ambiti, non è riuscita ancora ad affrontare al meglio le sfide della povertà e, perciò, non è riuscita a invertire la rotta sulla drammatica esclusione di milioni di persone che rimangono ai margini. Questo è un punto centrale nel dibattito sulle “cose nuove”.
Quando il mio predecessore Leone XIII scrisse la Rerum novarum alla fine del XIX secolo, non si concentrò sulla tecnologia industriale o sulle nuove fonti di energia, ma piuttosto sulla situazione dei lavoratori. È qui che risiede la forza evangelica del suo messaggio: l’attenzione principale era rivolta alla situazione dei poveri e degli oppressi di quel tempo. E, per la prima volta e con assoluta chiarezza, un Papa disse che le lotte quotidiane per la sopravvivenza e per la giustizia sociale erano di fondamentale importanza per la Chiesa. Leone XIII denunciò la sottomissione della maggioranza al potere «di pochi; così che un piccolo numero di uomini molto ricchi ha potuto imporre alle masse brulicanti dei poveri lavoratori un giogo poco migliore della schiavitù stessa». [8] Questa era la grande disuguaglianza dell’epoca.
Nell’Enciclica di Leone XIII non troviamo le parole “disoccupazione” o “esclusione”, perché all’epoca i problemi riguardavano piuttosto il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, lo sfruttamento, l’urgenza di una nuova armonia sociale e di un nuovo equilibrio politico, obiettivi che gradualmente sono stati raggiunti grazie a tante leggi sul lavoro e alle istituzioni di sicurezza sociale. Oggi, invece, l’esclusione è il nuovo volto dell’ingiustizia sociale. Il divario tra una “piccola minoranza” – l’1% della popolazione – e la stragrande maggioranza si è ampliato in modo drammatico.
Tale esclusione è una “novità” che Papa Francesco ha denunciato come “cultura dello scarto”, affermando con veemenza: «Gli esclusi non sono “sfruttati”, ma emarginati, “scarti”». [9]
Quando parliamo di esclusione, ci troviamo anche di fronte a un paradosso. La mancanza di terra, cibo, alloggio e lavoro dignitoso coesiste con l’accesso alle nuove tecnologie che si diffondono ovunque attraverso i mercati globalizzati. I telefoni cellulari, i social network e persino l’intelligenza artificiale sono alla portata di milioni di persone, compresi i poveri. Tuttavia, mentre sempre più persone hanno accesso a Internet, i bisogni primari rimangono insoddisfatti. Assicuriamoci che, quando vengono soddisfatti bisogni più sofisticati, quelli fondamentali non vengano trascurati.
Tale arbitrarietà sistemica fa sì che le persone siano private di ciò che è necessario e sommerse da ciò che è accessorio. In breve, la cattiva gestione genera e aumenta le disuguaglianze con il pretesto del progresso. E non avendo al centro la dignità umana, il sistema fallisce anche nella giustizia.
L’impatto delle “novità” sugli esclusi
Oggi non descriverò in modo esaustivo quali siano le “novità” prodotte in particolare dai centri di sviluppo tecnologico, ma sappiamo che esse hanno un impatto su tutti i principali ambiti della vita sociale: sanità, istruzione, lavoro, trasporti, urbanizzazione, comunicazione, sicurezza, difesa, ecc. Molti di questi impatti sono ambivalenti: sono positivi per alcuni Paesi e settori sociali, ma altri, invece, subiscono “danni collaterali”. Ancora una volta, questo è il risultato della cattiva gestione del progresso tecnologico.
La crisi climatica è forse l’esempio più evidente. Lo vediamo in ogni evento meteorologico estremo, che si tratti di inondazioni, siccità, tsunami, terremoti: chi ne soffre di più? Sono sempre i più poveri. Perdono quel poco che hanno quando l’acqua spazza via le loro case e spesso sono costretti ad abbandonarle senza avere un’alternativa adeguata per riprendere la loro vita. La stessa cosa accade quando, ad esempio, contadini, agricoltori e popolazioni indigene perdono le loro terre, la loro identità culturale e la produzione locale sostenibile a causa della desertificazione del loro territorio.
Un altro aspetto delle “novità” che colpisce in modo particolare gli emarginati ha a che fare con le angosce e le speranze dei più poveri in riferimento ai modelli di vita che oggi vengono costantemente promossi. Per esempio: come può un giovane povero vivere con speranza e senza ansia quando i social media esaltano costantemente un consumo sfrenato e un successo economico totalmente irraggiungibile?
E, ancora, un altro problema di non poco conto è rappresentato dalla diffusione della dipendenza dal gioco d’azzardo digitale. Le piattaforme sono progettate per creare dipendenza compulsiva e generare abitudini che creano assuefazione.
Non vorrei tacere poi sulla “novità” dell’industria farmaceutica, che certamente rappresenta per certi versi un grande progresso, ma non è priva di ambiguità; nella cultura attuale, non senza l’ausilio di certe campagne pubblicitarie, si propina una sorta di culto del benessere fisico, quasi un’idolatria del corpo e, in questa visione, il mistero del dolore è interpretato in modo riduttivo; ciò può portare anche alla dipendenza dall’assunzione di antidolorifici, la cui vendita va ovviamente a incrementare i guadagni delle stesse case di produzione. Ciò ha portato anche alla dipendenza dagli oppioidi, che sta devastando in particolare gli Stati Uniti; si pensi per esempio al fentanil, la droga della morte, la seconda causa di morte tra i poveri in quel Paese. Il dilagare di nuove droghe sintetiche, sempre più letali, non è solo un crimine dei trafficanti di droga, ma è una realtà che ha a che fare con la produzione dei farmaci e con il suo guadagno, privi di un’etica globale.
Vorrei anche sottolineare che lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni dipende dai minerali che spesso si trovano nel sottosuolo dei Paesi poveri. Senza il coltan della Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, molti dei dispositivi tecnologici che utilizziamo oggi non esisterebbero. Tuttavia, la sua estrazione dipende dalla violenza paramilitare, dal lavoro minorile e dallo sfollamento delle popolazioni. Il litio è un altro esempio: la competizione tra le grandi potenze e le grandi aziende per la sua estrazione rappresenta una grave minaccia alla sovranità e alla stabilità degli Stati poveri, al punto che alcuni imprenditori e politici si vantano di promuovere colpi di Stato e altre forme di destabilizzazione politica, proprio per mettere le mani sull’“oro bianco” del litio.
E, infine, vorrei accennare al tema della sicurezza. Gli Stati hanno il diritto e il dovere di proteggere i propri confini, ma ciò dovrebbe essere bilanciato dall’obbligo morale di fornire rifugio. Con l’abuso dei migranti vulnerabili, non assistiamo al legittimo esercizio della sovranità nazionale, ma piuttosto a gravi crimini commessi o tollerati dallo Stato. Si stanno adottando misure sempre più disumane – persino politicamente celebrate – per trattare questi “indesiderabili” come se fossero spazzatura e non esseri umani. Il cristianesimo, invece, si riferisce al Dio amore, che ci rende fratelli tutti e ci chiede di vivere da fratelli e sorelle.
Allo stesso tempo, mi incoraggia vedere come i movimenti popolari, le organizzazioni della società civile e la Chiesa stiano affrontando queste nuove forme di disumanizzazione, testimoniando costantemente che chi si trova nel bisogno è nostro prossimo, nostro fratello e nostra sorella. Questo vi rende campioni dell’umanità, testimoni della giustizia, poeti della solidarietà.
La giusta lotta dei movimenti popolari
Nella Rerum novarum, Leone XIII osservava che «le antiche corporazioni dei lavoratori sono state abolite nel secolo scorso, e nessun’altra organizzazione protettiva ha preso il loro posto». [10] I poveri sono diventati più vulnerabili e meno protetti. Oggi sta accadendo qualcosa di simile, perché i sindacati tipici del XX secolo rappresentano ormai una percentuale sempre più esigua dei lavoratori e i sistemi di sicurezza sociale sono in crisi in molti Paesi; perciò, né i sindacati né le associazioni dei datori di lavoro, né gli Stati né le organizzazioni internazionali sembrano in grado di affrontare questi problemi. Ma «uno Stato senza giustizia non è uno Stato», ci ricorda sant’Agostino. [11] La giustizia esige che le istituzioni di ogni Stato siano al servizio di ogni classe sociale e di tutti i residenti, armonizzando le diverse esigenze e gli interessi.
Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un vuoto etico, in cui il male entra facilmente. Mi viene in mente una parabola, la parabola dello spirito immondo che viene scacciato via ma, ritornando, trova la sua antica dimora pulita, in ordine e allora organizza una lotta ancora peggiore (cfr Mt 12,43-45). Nel vuoto ordinato lo spirito maligno è libero di agire. Le istituzioni sociali del passato non erano perfette, ma spazzando via gran parte di esse e adornando ciò che rimane con leggi inefficaci e trattati non applicati, il sistema rende gli esseri umani più vulnerabili di prima.
Perciò, i movimenti popolari, insieme alle persone di buona volontà, i cristiani, i credenti, i governi sono chiamati con urgenza a colmare quel vuoto, avviando processi di giustizia e solidarietà che si diffondano in tutta la società, perché, come ho già avuto modo di affermare, «le illusioni ci distraggono, i preparativi ci guidano. Le illusioni cercano un risultato, i preparativi rendono possibile un incontro». [12]
Nell’Esortazione apostolica Dilexi te ho voluto ricordare che «vari movimenti popolari, composti da laici e guidati da leader popolari, […] sono stati spesso guardati con sospetto e persino perseguitati». [13] Eppure le vostre lotte sotto la bandiera della terra, della casa e del lavoro per un mondo migliore meritano incoraggiamento. E come la Chiesa ha accompagnato la formazione dei sindacati in passato, oggi dobbiamo accompagnare i movimenti popolari. Questo significa accompagnare l’umanità, camminare insieme nel rispetto condiviso della dignità umana e nel desiderio comune di giustizia, amore e pace.
La Chiesa sostiene le vostre giuste lotte per la terra, la casa e il lavoro. Come il mio predecessore Francesco, credo che le vie giuste partano dal basso e dalla periferia verso il centro. Le vostre numerose e creative iniziative possono trasformarsi in nuove politiche pubbliche e diritti sociali. La vostra è una ricerca legittima e necessaria. Chissà se i semi dell’amore, che voi seminate, piccoli come semi di senape (cfr Mt 13,31-32, Mc 4,30-32, Lc 13,18-19) potranno crescere in un mondo più umano per tutti e aiutare a gestire meglio le «cose nuove».
La Chiesa e io vogliamo esservi vicini in questo cammino. Continuiamo a elevare le nostre preghiere a Dio Onnipotente. Con voi, nella preghiera, imploriamo il Padre di ogni misericordia perché vi protegga e vi riempia del suo amore inesauribile. Che Egli, nella sua infinita bontà, vi dia il coraggio di una profezia evangelica, la perseveranza nella lotta, la speranza nel cuore, la creatività poetica. Vi affido alla guida materna di Maria Santissima. E dal profondo del cuore vi benedico.
Grazie, grazie a tutti voi! E andate avanti nel cammino, con gioia e speranza! Grazie. Entonces oremos juntos como Jesús nos ha enseñado.
[Recita del Padre Nostro in spagnolo. Benedizione]
________________________________
[1] “ Tierra, techo, trabajo”, le tre “T” in spagnolo.
[2] Francesco, Videomessaggio, 16 ottobre 2021.
[3] Videomessaggio in occasione della presentazione a Lampedusa della candidatura del progetto “Gesti dell’accoglienza” alla lista del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, 12 settembre 2025.
[4] Francesco, Lett. enc. Laudato si’, 49.
[5] Id., Esort. ap. Evangelii gaudium, 202.
[6] Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 42.
[7] Cfr Agostino, Discorso 259, 3.
[8] Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 3.
[9] Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 53.
[10] Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 3.
[11] Agostino, De civitate Dei, XIX, 21, 1.
[12] Leone XIV, Udienza generale, 6 agosto 2025.
[13] Leone XIV, Esort. ap. Dilexi te, 80.