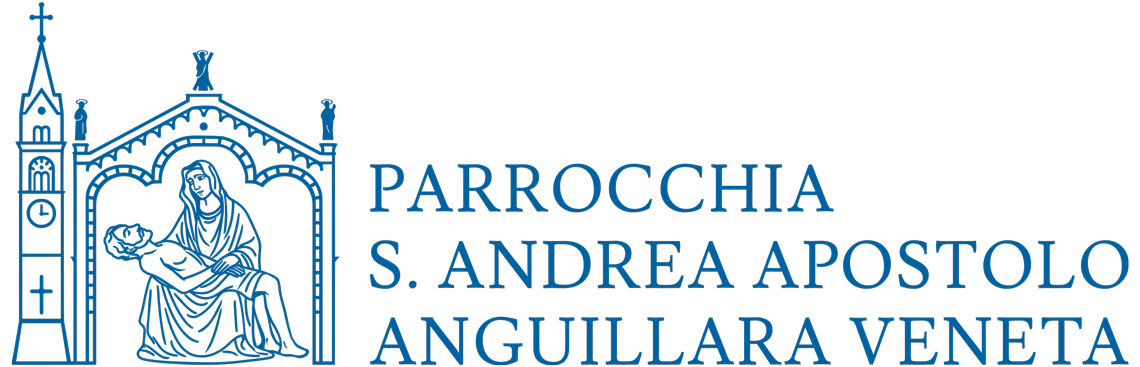Commemorazione della Dichiarazione Conciliare Nostra Aetate (28 ottobre 2025)
Stimati Capi e Rappresentanti delle Religioni del Mondo,
Distinti Membri del Corpo Diplomatico Accreditato presso la Santa Sede,
Cari fratelli e sorelle,
la pace sia con voi!
È con gioia e profonda gratitudine che porgo i miei cordiali saluti ed esprimo il mio sincero ringraziamento per la vostra presenza a questa commemorazione dell’innovativo documento Nostra Aetate. Il tema dell’incontro di questa sera è “Camminando insieme nella Speranza.” Sessant’anni fa venne piantato un seme di speranza per il dialogo interreligioso. Oggi la vostra presenza testimonia che questo seme è cresciuto in un albero maestoso, i cui rami si estendono ampiamente, offrendo rifugio e producendo ricchi frutti di comprensione reciproca, amicizia, cooperazione e pace.
Per sessant’anni, uomini e donne hanno lavorato per coltivare Nostra Aetate. Hanno annaffiato il seme, curato il terreno e lo hanno protetto. Alcuni hanno persino dato la loro vita — martiri del dialogo, che si sono opposti alla violenza e all’odio. Ricordiamoli oggi con gratitudine. Come cristiani, insieme ai nostri fratelli e sorelle di altre religioni, siamo ciò che siamo grazie al loro coraggio, al loro sudore e al loro sacrificio.
A tal proposito, vi ringrazio sinceramente per la vostra collaborazione con il Dicastero per il Dialogo Interreligioso, la Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo presso il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e con la Chiesa Cattolica nei vostri paesi d’origine. Grazie per aver accettato il nostro invito e per aver onorato questa occasione con la vostra presenza.
Cari fratelli e sorelle, la vostra amicizia e stima per la Chiesa Cattolica si sono manifestate in modo speciale al tempo della malattia e della morte di Papa Francesco attraverso i sentiti messaggi di cordoglio che avete inviato, le preghiere offerte nei vostri Paesi e la presenza di coloro che hanno potuto partecipare al suo funerale. Quella stessa amicizia si è manifestata nuovamente attraverso i vostri messaggi augurali per la mia elezione a Papa e la presenza di alcuni di voi alla Messa di inizio pontificato. Tutti questi gesti testimoniano il vincolo profondo e duraturo che condividiamo; un vincolo che custodisco con grande affetto. Se la Dichiarazione Nostra Aetate ha nutriti i legami tra noi, sono convinto che il suo messaggio rimanga altamente rilevante oggi. Riflettiamo, quindi, su alcuni dei suoi insegnamenti più significativi.
In primo luogo, Nostra Aetate ci ricorda che l’umanità sta convergendo sempre di più, e che è compito della Chiesa promuovere l’unità e l’amore tra gli uomini e le donne, e tra le nazioni (cfr. n.1).
In secondo luogo, indica ciò che tutti condividiamo. Apparteniamo a una sola famiglia umana — una nell’origine e una anche nel nostro fine ultimo. Inoltre, ogni persona cerca risposte ai grandi enigmi della condizione umana (cfr. n.1).
In terzo luogo, le religioni di tutto il mondo cercano di rispondere all’irrequietezza del cuore umano. Ognuna, a modo proprio, offre insegnamenti, modi di vita e riti sacri che aiutano a guidare i propri fedeli verso la pace e il senso della vita (cfr. n. 2).
In quarto luogo, la Chiesa cattolica non rifiuta nulla di ciò che è vero e santo in queste religioni, che “riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini” (n. 2). Le considera con sincera riverenza e invita i suoi figli e le sue figlie, attraverso il dialogo e la collaborazione, a riconoscere, preservare e promuovere ciò che è spiritualmente, moralmente e culturalmente buono in tutti i popoli.
Non dobbiamo infine dimenticare come il testo di Nostra Aetate si sia effettivamente sviluppato. Inizialmente, Papa Giovanni XXIII incaricò il cardinale Agostino Bea di presentare al Concilio un trattato che descrivesse un nuovo rapporto tra la Chiesa cattolica e l’ebraismo. Possiamo dire, quindi, che il quarto capitolo, dedicato all’ebraismo, è il cuore e il nucleo generativo dell’intera Dichiarazione.
Per la prima volta nella storia della Chiesa, abbiamo un testo dottrinale con una base esplicitamente teologica che illustra le radici ebraiche del Cristianesimo in modo biblicamente fondato. Allo stesso tempo, Nostra Aetate (n. 4) prende una posizione ferma contro tutte le forme di antisemitismo. Così, nel capitolo seguente, Nostra Aetate insegna che non possiamo veramente invocare Dio, Padre di tutti, se ci rifiutiamo di trattare in modo fraterno ogni uomo e ogni donna, creati a immagine di Dio. In effetti, la Chiesa respinge tutte le forme di discriminazione o molestie per motivi di razza, colore, condizione di vita o religione (cfr. n. 5). Questo documento storico, quindi, ci ha aperto gli occhi su un principio semplice ma profondo: il dialogo non è una tattica o uno strumento, ma un modo di vivere, un cammino del cuore che trasforma tutti i suoi protagonisti, chi ascolta e chi parla. Inoltre, percorriamo questo cammino non abbandonando la nostra fede, ma restando saldamente al suo interno.
Perché il dialogo autentico non nasce dal compromesso, ma dalla convinzione, cioè dalle radici profonde della nostra stessa fede che ci danno la forza di tendere la mano agli altri con amore. Sessant’anni dopo, il messaggio di Nostra Aetate rimane più urgente che mai. Durante il suo Viaggio Apostolico a Singapore, in un incontro interreligioso, Papa Francesco ha incoraggiato i giovani con le seguenti parole: “Dio è per tutti, e quindi, siamo tutti figli di Dio” (Incontro Interreligioso con i Giovani, 13 settembre 2024). Questo ci chiama a guardare oltre ciò che ci separa e a scoprire ciò che ci unisce tutti. Eppure oggi ci troviamo in un mondo in cui questa visione è spesso oscurata. Vediamo muri che si ergono di nuovo tra le nazioni, tra le religioni, persino tra vicini. Il frastuono della guerra, le ferite della povertà e il grido della terra ci ricordano quanto fragile rimane la nostra famiglia umana. Molti si sono stancati delle promesse; molti hanno dimenticato come sperare.
Come capi religiosi, guidati dalla saggezza delle nostre rispettive tradizioni, condividiamo una responsabilità sacra: aiutare il nostro popolo a liberarsi dalle catene del pregiudizio, dell’ira e dell’odio; aiutarlo a elevarsi al di sopra dell’egoismo e dell’autoreferenzialità; aiutarlo a sconfiggere l’avidità che distrugge sia l’animo umano sia la terra. In questo modo, possiamo guidare i nostri popoli a diventare profeti del nostro tempo, cioè voci che denunciano la violenza e l’ingiustizia, curano le divisioni e proclamano la pace per tutti i nostri fratelli e sorelle. In quest’anno la Chiesa Cattolica celebra il Giubileo della Speranza. Sia la speranza sia il pellegrinaggio sono realtà comuni a tutte le nostre tradizioni religiose. Questo è il cammino che Nostra Aetate ci invita a continuare: camminare insieme nella speranza. Quando lo intraprendiamo, accadono meraviglie: i cuori si aprono, si costruiscono ponti e vengono tracciati nuovi sentieri là dove nessuno sembrava possibile. Questo non è l’impegno di una sola religione, di una sola nazione o anche di una sola generazione.
È un compito sacro per tutta l’umanità mantenere viva la speranza, mantenere vivo il dialogo e mantenere vivo l’amore nel cuore del mondo.
Miei cari fratelli e sorelle, in questo momento cruciale della storia, ci è stata affidata una grande missione: risvegliare in tutti gli uomini e le donne il loro senso di umanità e del sacro. Questo, amici miei, è esattamente il motivo per cui ci siamo riuniti in questo luogo, avendo la grande responsabilità, come capi religiosi, di portare speranza a un’umanità spesso tentata dalla disperazione. Ricordiamo che la preghiera ha il potere di trasformare i nostri cuori, le nostre parole, le nostre azioni e il nostro mondo. Ci rinnova da dentro, riaccendendo in noi lo spirito di speranza e di amore.
A questo proposito, ricordo le parole di San Giovanni Paolo II, pronunciate ad Assisi nel 1986: “Se il mondo deve continuare, e gli uomini e le donne devono sopravvivere su di esso, il mondo non può fare a meno della preghiera” (Ai Rappresentanti delle Chiese e Comunità Ecclesiali e delle Religioni del Mondo, 27 ottobre 1986).
Invito quindi ciascuno di voi a fermarsi ora per un momento in preghiera silenziosa. Possa la pace scendere su di noi e riempire i nostri cuori.